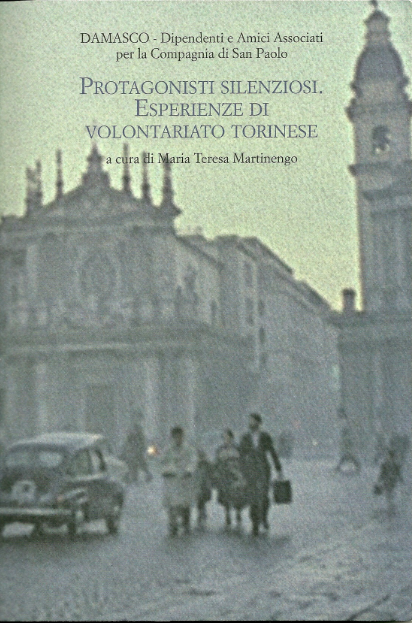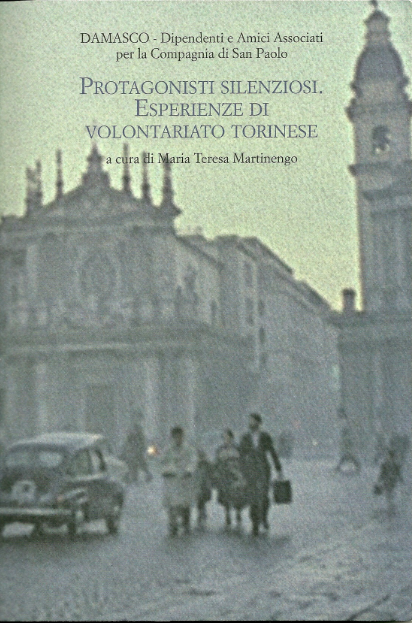
|
| Titolo: | Protagonisti silenziosi.
Esperienze di volontariato torinese. |
| Autore: | Maria Teresa Martinengo. |
| Editore: | DAMASCO
(Dipendenti e Amici Associati per la Compagnia di San Paolo). |
|
 Maria Valente è nata nel 1917 a Cologna Veneta (Verona) "in una famiglia di persone che vivevano il Vangelo", la maggiore di sei sorelle. Ha dedicato la vita al sostegno delle giovani donne in difficoltà, alla promozione del diritto delle madri nubili a tenere con sé il proprio figlio e al diritto dei bambini di avere una famiglia.
Maria Valente è nata nel 1917 a Cologna Veneta (Verona) "in una famiglia di persone che vivevano il Vangelo", la maggiore di sei sorelle. Ha dedicato la vita al sostegno delle giovani donne in difficoltà, alla promozione del diritto delle madri nubili a tenere con sé il proprio figlio e al diritto dei bambini di avere una famiglia.
 Negli anni 60 ha dato vita alla comunità Casa Nostra dove vengono accolti minori allontanati dalla famiglia e madri con i loro figli.
Negli anni 60 ha dato vita alla comunità Casa Nostra dove vengono accolti minori allontanati dalla famiglia e madri con i loro figli.
|

|
"Oggi non si può più immaginare che cosa volesse dire per una ragazza, cinquant'anni fa, rimanere incinta fuori dal matrimonio. La sua e quella del figlio erano vite spezzate, comunque divise".

"Eravamo gente di campagna, benestanti", racconta Maria.

"Mia madre faceva in modo di dare sempre qualcosa anche al frate che passava col sacco per i poveri. Ce n'era per tutti, sempre. Non so come potesse, con una famiglia così grande, pensare a tutti. Era straordinaria al punto che ancora adesso con le mie sorelle ci viene da dire, quando non si è tutte d'accordo su una decisione da prendere, "la mamma non sarebbe contenta", tanto era grande l'autorevolezza che aveva".
A causa della salute cagionevole che da un certo momento in poi segna la madre, Maria si occupa delle sorelle più piccole. "La mia vita era piena… non ho sentito il bisogno di sposarmi e non mi sono pentita. Comunque, per me era difficile immaginare di vivere un rapporto troppo stretto, non sarei riuscita. Mi domando quante donne troverò in Paradiso - io ho fede e ci credo - che abbiano saputo vivere accanto ad un uomo, allevando i figli e occupandosi della famiglia, sempre fedeli, sempre ligie al dovere verso il marito e i figli. Non lo so, non importa.

C'era qualcosa che doveva riempirmi di più, farmi capire qualcosa di più…

Allora mi piacevano le suore della Nigrizia, le missionarie del Comboni, per il loro spirito libero, gioioso. Servire Dio nella gioia mi pareva una soluzione ideale".

È appena finita la guerra e di ritorno da una vacanza in montagna, a Bressanone, con le tre sorelle più piccole bisognose di aria buona, Maria decide di fermarsi a Trento per un corso di esercizi spirituali tenuto da padre Cenere, gesuita. "Misi le mie sorelle sul treno e rimasi a Trento, anche se non conoscevo nessuno. Il padre gesuita si occupava dell'apostolato della preghiera e svolgeva la sua missione in tutta l'Alta Italia. Parlava della devozione al Sacro Cuore, teneva conferenze alle giovani operaie e alle studentesse. In quelle occasioni alcune ragazze mi dicevano "Mi piacerebbe vivere bene come dice lei, ma non posso più. Sono uscita una sera in compagnia, con gli amici abbiamo fatto tardi…" bastava rimanere una notte fuori con gli amici per essere considerate poco di buono. Come si fa a capire queste cose adesso? Non parliamo poi se una rimaneva incinta: la vita diventava una sofferenza che oggi è inimmaginabile".

Un giorno padre Cenere chiede a Maria cosa fa nella vita. ""Aiuto mia madre che non ha salute: siamo tante sorelle e lei da sola non può farcela. Mi occupo anche delle opere parrocchiali. Non mi annoio", gli rispondo. Lui allora dice: "In Piemonte ci sono delle maestre che si dedicano a giovani in difficoltà che, se lasciate sole, nel momento del bisogno vanno a finire male". Il padre - ricorda Maria - doveva aver detto "Si stanno preparando…" ma io non ho capito o non ho voluto capire. E ho risposto: "Per queste cose ci vuole vocazione, io non ce l'ho". E sono andata via.

Da quel momento dentro di me si è scatenata una lotta, un vero tormento. Mi dicevo "Io non ho bisogno di altre attività" e intanto mi chiedevo come avrebbe potuto essere la mia vita in comunità. Dicevo al Signore di non dare la vocazione proprio a me, poi però mi tornava il pensiero "Quelle ragazze vanno a finire male…". Mi ripetevo: "Quanto sei vile tu che rifiuti la comunità, la vita metodica, che senti la divisa come un peso".

Mi era capitato, in quel tempo, di leggere la vita di un'attrice di teatro, Eva Levalier: era ammirata ed osannata, ma non era soddisfatta, le mancava qualcosa, voleva lasciare le scene. Una volta aveva tentato di annegare, ma era stata salvata da un ammiratore. Dopo quell'episodio aveva fatto di tutto per cambiare il suo modo di vivere, era andata a Lourdes, faceva penitenza. Aveva adottato un modo di dire curioso: "Crepa porcello, ma resisti". Quelle parole le ho fatte mie e mi sono detta: "È meglio una dura realtà alla sospensione. Mi spaventa la vita di comunità, ma la proposta del padre mi attira. Decidi. Resisti"".

Maria va quindi alla scoperta della Comunità.

Impiega tre giorni per giungere a destinazione. La guerra è appena finita, la linea ferroviaria non funziona: l'unica possibilità è salire su un camion diretto in Piemonte.

"Dovevo arrivare a Salabue, provincia di Alessandria, diocesi di Casale Monferrato, alla scuola dove alloggiavano quelle maestre. Padre Cenere aveva scritto loro che sarei andata a vedere, ma io mi era detta che se le avessi raggiunte non sarei più tornata indietro. Non mi fidavo di me stessa".

Gli inizi, tra i piemontesi, i "bogianen", in un ambiente tanto diverso dal suo, per Maria sono duri, costano lacrime. "Il programma da svolgere era chiaro, ma ancora lontano da essere concretizzato. Era necessario avere una casa e la trovammo a Solonghello Monferrato: grande e spaziosa, ma senza riscaldamento. Era stata offerto al paese per farne una scuola privata con la quarta e la quinta elementare per i bambini che non avevano altre scuole vicine. A noi venne data in uso con l'impegno di dedicarci anche all'istruzione. Il compito di far scuola toccò a me.

Si viveva in una povertà assoluta, ma la bellezza di avere un ideale condiviso e di essere in armonia, di avere un'intesa tra noi, era più importante di qualsiasi difficoltà. Ricordo una volta che in sei dividemmo una caramella…

In paese avevano bisogno di iniezioni e noi, "le suore", come venivamo indicate, ci eravamo preparate frequentando corsi della Croce Rossa e della Croce Verde, e andavamo a farle. Allevavamo qualche oca, aiutavamo il fornaio a fare il pane. Facevamo quanto era possibile per bastare a noi stesse.

Eravamo religiose laiche, in casa portavamo un grembiule nero. C'era l'impronta della comunità religiosa, ma molto bella e gioiosa. L'ideale di tutte era aiutare le ragazze: si cercava di trovare la via e i mezzi per prevenire che finissero male.

Vivevamo di fede ed eravamo disposte ad accettare le situazioni più diverse, anche se dure, pur di riuscire. Non ne avvertivamo il peso. Intanto il nostro vescovo, monsignor Angrisani, diceva: "Non sarete mai preparate abbastanza per svolgere il compito che vi siete prefissate"…

In quello stesso periodo, una religiosa dal grande carisma, suor Lucia Amati, aveva dato vita ad una scuola per educatori professionali ed esortava le religiose delle varie strutture a partecipare ai corsi di formazione, corsi che stavano diventando indispensabili per chi voleva continuare nella propria missione.

Per noi la preparazione professionale è sempre stata in primo piano, per gli educatori e anche per le ospiti". A casa, dove Maria torna di tanto in tanto, la famiglia e gli amici sostengono il progetto, offrendo anche aiuti economici.

"Era tutto da fare per la sistemazione definitiva di cui avevamo bisogno: ormai era diventato indispensabile avere "una nostra casa". E ci riuscimmo. Riuscimmo a comprare una villa, la parte nobile di un convento a Moncalvo Monferrato, e nel 1949 costituimmo l'Associazione Villa Serena.

Da quel momento cominciammo a raccogliere ragazze. Erano giovani che venivano a cercare lavoro presso i parenti, gente disperata che emigrava dal Friuli o dal Meridione.

Una quindicenne arrivata dal Friuli a Casale Monferrato presso parenti, in cerca di lavoro, era incappata in cattive compagnie e conduceva una vita deviante. Il vescovo di Casale, che seguiva la nostra Opera, ci disse: "C'è una ragazza alla Protezione della Giovane che ha bisogno di voi, potete prenderla?". Era tanto disturbata, non accettava la vita di comunità e faceva dispetti a tutto andare. Per fare un esempio: invece di usare il bagno andava sul terrazzo…

Un giorno la ragazza riesce a scappare saltando il muro di cinta. La polizia ci chiama per sentire la nostra disponibilità a tenerla ancora e noi andiamo a prenderla. Ricordo il funzionario della questura che con le lacrime agli occhi ci dice "Chi ve lo fa fare?". Ma se uno è cresciuto in una famiglia come la mia, si sente debitore. La ricchezza nostra non è di tutti. Io non tengo a tanti "Pater noster" ma a vivere la carità sì".

Non era un'esistenza facile, ammette Maria.

"Mi veniva da dire alla madre direttrice che io non potevo vivere con serpenti come quella ragazza, che la mandasse via o me ne sarei andata via. Però mi ero presa l'impegno di resistere e ho resistito. Era l'accettazione piena del progetto, l'istruzione, la preparazione al lavoro e gli interessi proposti alle nostre ospiti, che riuscivano a sanare tanta inquietudine.
La ragazza che era scappata si è poi sposata e ci scriveva: "Il mio tempo libero lo dedico alle ragazze madri di un istituto perché ho bisogno di sdebitarmi del bene che ho ricevuto". In quell'epoca, gli anni 50, queste donne hanno saputo rifarsi una vita e, pur avendo figli loro, molto spesso hanno accolto bambini di altri nelle loro famiglie.

Era forte in noi la consapevolezza che un bambino ha bisogno di una famiglia, del contatto con la madre, in modo particolare nei primi mesi di vita.

A Villa Serena di Moncalvo abbiamo avuto una ragazza che ci era stata inviata dai servizi sociali di una località vicino a Torino. L'avevano mandata perché era sola, ammalata e nell'impossibilità di accudire suo figlio. Ripeteva tutto il giorno angosciata "Ci può essere una donna più disgraziata di me? Ho messo al mondo un figlio e non posso allevarlo". Erano stati separati: la mamma in comunità a Villa Serena, del bimbo si occupava la Provincia, l'ente competente.

Monsignor Chiavazza
(1)
Monsignor Carlo Chiavazza, fondatore del settimanale Il nostro tempo, rappresentava in quella circostanza la Chiesa torinese.
, tramite monsignor Moietta, il rappresentante legale di Villa Serena
(2)
Monsignor Vittorio Moietta, futuro vescovo di Nicastro, era direttore spirituale del Seminario di Casale e di Villa Serena.
, ci chiamò poi a gestire un'altra opera, Il Pozzo di Sicar di Torino, ed io proposi a quella ragazza di venire con noi perché avremmo potuto prendere con lei anche il suo bambino. Lei accettò con entusiasmo e a Casale, mentre andavamo dal vescovo per ulteriori chiarimenti in vista dell'inizio della nuova attività, mi disse: "Se avessi vinto milioni e milioni al Totocalcio non mi sentirei così felice: oggi vado per la strada sentendomi libera e padrona di me stessa". Con l'aiuto della comunità, infatti, si era liberata da una relazione che la schiavizzava e ora poteva ricongiungersi con suo figlio. Ho ancora davanti agli occhi l'espressione di sollievo di quella mamma".

E la storia va avanti.

A Torino, Maria arriva in Lambretta.

"Il Pozzo di Sicar era un'opera ben tenuta, aveva fatto tanto bene, ma era un po' lontana dal nostro stile. A sostenerla era un comitato di madame che raccoglievano fondi facendo feste e varie iniziative. A me sembrava che per quel gruppo di signore - indubbiamente animate a fare del bene - Il Pozzo fosse anche un'opportunità per trovare persone da mettere a servizio già sperimentate durante la permanenza in comunità. Le ragazze ospiti erano gestanti che per la loro condizione non erano più accettate dalle rispettive famiglie. Il loro futuro era scritto: quasi tutte sarebbero diventate persone di servizio per vivere e per pagare una balia o la comunità.

Non posso dimenticare l'urlo di una ragazza di buona famiglia il giorno in cui ha dovuto staccarsi dalla figlia per andare a servizio.

La direttrice uscente, che aveva dato la vita per quell'opera, viveva ancora lì in attesa di un alloggio per sé. Mangiava in sala da pranzo e anch'io con lei, ma solo dopo avere servito in refettorio le ragazze. Ci tenevo a non farla soffrire, ma era chiaro che bisognava cambiare molte cose. Ricordo l'atmosfera, ricordo l'anziano sacerdote che alle sette del mattino diceva la Messa alla quale tutti dovevano partecipare. Confesso che a me pesava molto come era organizzata la preghiera. Mia madre tutte le sere recitava il rosario, ma poi quel rosario lo viveva…

Ripenso all'impatto con le ospiti quando sono arrivata: una decina di gestanti - chi all'inizio della gravidanza e chi alla fine - tutte con un grembiule nero, che mangiavano con certe stoviglie tristi, sedute su sgabelli. In seguito il grembiule è diventato azzurro e la casa presto si è animata con la nascita di una decina di bambini che potevano restare con le loro madri anche di notte.

A Moncalvo avevamo accolto giovani nate al Pozzo di Sicar, ma subito separate dalle madri e trasferite in vari altri istituti. Erano ragazze che non avevano avuto il calore di una famiglia e che sembravano senza speranza. Noi eravamo convinte che per aiutare gli altri si dovesse essere attenti ai loro bisogni. E che se il rifiuto subito aveva causato delle ferite, l'accettazione, la fiducia, e l'affetto potevano curare.

Nel gennaio 1959 lasciammo con profondo rimpianto Il Pozzo di Sicar. La mia salute cagionevole fu all'origine del distacco. Con alcune mamme prive di altre soluzioni, e i loro figli, ci trasferimmo in via Luca della Robbia, in una villetta presa in affitto. La casa era bella, tranquilla e con le tante attività avviate faceva pensare ad un alveare. Ad un buon prezzo acquistammo da una ditta che era fallita alcune macchine speciali per insegnare e realizzare capi pregiati di maglieria. Lavoravamo per un maglificio del quartiere, dovevamo andare a ritirare la merce e riportarla. E siccome eravamo privi di un veicolo per il trasporto, ci servivamo di un carrettino a mano del quale conserviamo ancora la targa". Le regole erano, ancora una volta, studio, lavoro, vita di relazione perché ognuno potesse arrivare quanto prima a bastare a se stesso senza avere più bisogno della comunità.

Alla fine del '59 viene a mancare la professoressa Paron che dirigeva "Il nido bimbi senza mamma" di via Villar Focchiardo. Al "Nido" sono ospitati una trentina di bambini da 0 a 3 anni e Maria riceve l'incarico di gestirlo. "I bambini venivano trasferiti altrove dopo aver compiuto i tre anni, la maggior parte - ricorda Maria - trovava sistemazione fuori Torino, una situazione che impediva alle mamme di vederli spesso e che creava grandi difficoltà.

Nel periodo estivo del grande caldo spostavamo il "Nido" a Cuorgné, in una Casa del Fascio che aveva un grande salone, un ufficio, un grande terrazzo e tanto verde intorno. Nel salone si installavano quattro box con otto posti letto ciascuno. Dovevamo portare quanto occorreva per vivere, perciò il giorno della partenza si smontavano i lettini, si prendeva la biancheria e le stoviglie, e si caricava tutto sul camion che partiva presto per consentire di mettere in funzione quella grande casa nello stesso giorno di arrivo dei bambini. Poi, aspettavamo il pullman e partivamo con i piccoli.

Erano tante le richieste di ricovero e si è cominciato ad accettare anche i bambini insieme alle loro mamme. A pensarci ora sembrano cose impossibili, ma il beneficio psico-fisico che ricevevano i bimbi ci appagava tanto da alleviarci la fatica.

In seguito, in un modo veramente provvidenziale, abbiamo ricevuto la casa di Viù, dove tutte le comunità nei mesi estivi, ogni anno, hanno potuto e possono godere la montagna.

Il bisogno di avere una struttura nostra, adeguata, ci ha spinto a cercare e ad acquistare la casa di Strada Villa d'Aglié che ci ha permesso di unire le due attività: via Luca della Robbia e via Villar Focchiardo. Nel '62 l'abbiamo inaugurata e funziona tuttora con due comunità alloggio. In seguito è capitata l'ulteriore occasione, interessante sotto tutti gli aspetti, di poter avere una casa attigua con terreno e un ampio spazio verde. Questa soluzione era stata ritenuta necessaria perché pareva più proficuo che mamme e bambini fossero separati dai bambini soli. L'idea fu però scartata dalla nostra direzione di Moncalvo: lontana dalla vita di città, non era riuscita ad afferrarne l'utilità ed i vantaggi".

È in quel periodo che avviene la dolorosa separazione da Villa Serena. "La città dava la possibilità di fare tante cose per l'istruzione e l'apprendistato delle ragazze in vista di una futura occupazione, ma su alcune iniziative che qui ritenevamo necessarie non riuscivamo ad essere in sintonia con Moncalvo. Così, nonostante ci si volesse un bene dell'anima, ci siamo divisi. È stato un momento duro non solo per il legame affettivo, ma anche perché là avevamo il riconoscimento giuridico, mentre qui siamo rimaste con il nostro desiderio di bene, l'esperienza e tanta sofferenza. Non potevamo più servirci del nome di Villa Serena, eravamo povere e sole. Dovevamo ripartire dal niente e i bambini sentivano che si stava male. Le mamme preoccupate domandavano: "È vero che possono rimanere ancora i nostri figli?".

Un giorno un bambino dice alla mamma, durante una passeggiata, "Non voglio andare via, torniamo a casa nostra". Ecco, "Casa Nostra". Con questo nome abbiamo chiamato l'Opera che continua ancora oggi, qui a Torino.

Era il 1966. Da allora è avvenuto un grande cambiamento nell'organizzazione. In bene, certo. Oggi all'educatore è richiesta una preparazione specifica con laurea in Scienze dell'educazione. Altri titoli non sono validi, tutti gli educatori hanno quella laurea. Anche gli addetti ai lavori manuali devono avere una qualifica.

Ma i cambiamenti sono stati anche di altro genere. Nelle persone che adesso avviciniamo si è fatto largo un vuoto che fa spavento. Non so dire se si riscontra più nei poveri o nei ricchi. La gente semplice di un tempo poteva essere ignorante per mancanza di istruzione, ma aveva acume e credibilità. Oggi il lavoro di recupero è diventato complesso, si sommano difficoltà e problemi di ogni genere. Per noi, comunque, oggi come 43 anni fa è importante riuscire a mettere in grado ogni madre di prendersi cura del suo bambino e di se stessa ed arrivare quanto prima ad una piena autonomia.

Nel '68 abbiamo inaugurato l'attuale sede. Prima di realizzarla sono stati fatti tanti incontri con amici volontari, professionisti competenti e qualificati, per studiare i bisogni e realizzare un progetto adeguato. Desideravamo una struttura che "sapesse di casa" ma il piano regolatore non lo prevedeva perché il progetto si inseriva nella zona precollinare. Così siamo arrivati a progettare e costruire in un'unica struttura ambienti singoli per ogni mamma con il suo bambino, un minialloggio con angolo cottura e servizi. Questo per far sì che ognuna avesse indipendenza - naturalmente seguita dalle educatrici - e diventasse in grado di creare un valido rapporto con il figlio, impegnandosi a raggiungere l'autonomia fino a lasciare la comunità. Abbiamo costruito 18 minialloggi per altrettante mamme, sei per ogni piano.

Delle mamme abbiamo sempre curato molto l'istruzione in vista di un'occupazione gratificante. Ricordo una ragazza che soffriva perché le altre giovani della sua comunità erano soddisfatte del loro impiego mentre lei faceva l'operaia e l'ambiente grossolano della fabbrica le pesava: si mise a studiare con passione e fece l'esame con un buon risultato. Era felice! "È il giorno più bello della mia vita", diceva commossa. E pensare che aveva dato solo l'esame di quinta elementare. Quella mamma ne ha poi fatta di strada perché è riuscita a creare in proprio una piccola attività e a rifarsi una famiglia con il padre di sua figlia.

Di analfabete e di semianalfabete ne sono arrivate tante dal Meridione negli anni 60 e 70, e a quasi tutte è venuto il gusto di apprendere. Alcune hanno continuato gli studi fuori dalla comunità pur lavorando. Spesso ne incontro qualcuna sul lavoro, in ospedali, ambulatori, uffici, e mi sento dire: "Zia Maria ti ricordi di me?"".

La normativa attuale prevede che una comunità sia composta da sei nuclei familiari e che non ci siano più di due comunità allo stesso numero civico. "Fa male - dice Maria - pensare a questo limite perché in questo campo c'è tanto bisogno. Ma così è la legge. La nostra è una struttura accreditata presso il Comune di Torino, perciò si dà la precedenza ai casi che propone l'ente.

Da sempre nelle nostre comunità arrivano bambini con provvedimento di allontanamento dalla famiglia disposto spesso dal Tribunale per i Minori. La loro situazione è un ripetersi ciclico. Se non hai non puoi dare. In genere sono figli di genitori che non hanno ricevuto niente. Fanno tutti molta pena, bimbi e genitori, e ci vuole molto tatto nel gestire questi casi, per dare una mano a padre e madre, quando è possibile.

Spesso i bambini sono distrutti, sia fisicamente che psicologicamente. Ne ricordo uno, tra i tanti: è arrivato con grossi lividi provocati dalla violenza subita in famiglia. Era tanto sofferente ed io gli stavo vicino parlandogli, cercando di rincuorarlo… "Io non ho il papà", mi dice. "Però hai la tua mamma e lei ti vuole bene", dico io. Il piccolo non risponde. Ripeto "Ma la tua mamma ti vuole bene". Lui alza le spalle. "Alla mia mamma interessa di più stare col suo amico". Questa risposta fa stringere il cuore: quanto incide in un bambino la mancanza di cure materne, rispetto al dolore fisico subito?".

Casa Nostra conta sulla presenza di molti volontari.

"Sono persone singole o coppie di sposi che chiedono di poter mettere a disposizione parte del loro tempo libero per "fare qualcosa di bene". Negli anni si sono promossi corsi di formazione tenuti da persone altamente qualificate e si è stampato un opuscoletto che illustra il comportamento da tenere sia con i bambini che con gli educatori.

I volontari vengono in contatto con i responsabili delle diverse comunità e, secondo la loro disponibilità, affiancano gli educatori nello svolgimento di attività ludiche e scolastiche. Il contatto con persone equilibrate e sagge porta i bambini a rapportarsi positivamente con gli adulti e, nel tempo, eventualmente ad affrontare l'affidamento o l'adozione.

Un grande aiuto viene anche dalle signore che frequentano l'Università della Terza Età. Alcune di loro si alternano in laboratorio nel curare i capi di vestiario e la biancheria dei bambini, realizzando tra loro, nel frattempo, un bel rapporto di allegra amicizia. Dicono "Abbiamo creato tra di noi una comunità nella comunità".

Tra i volontari che si sono avvicendati nel tempo, alcuni, forti dell'esperienza acquisita a Casa Nostra, hanno aperto braccia e cuore per fare della loro casa una "Casa Famiglia", pur mantenendo rapporti di amicizia con l'opera: Lucia e Paolo, Carlo e Vera, Concetta e Riccardo, Ornella e Roberto e altri.

Una volta c'erano i grandi istituti grazie a Dio oggi superati, ma c'era anche chi, come don Viotti
(3)
Don Giuseppe Viotti, fondatore del Santuario Nostra Signora di Lourdes a Giaveno, aveva precorso i tempi dando vita a comunità con pochi bambini ospiti, il modello adottato dopo la chiusura degli istituti.
a Giaveno, aveva comunità-alloggio con sei-otto bambini, gestite da educatrici che fungevano da mamme. Loro, poi, non sono riuscite ad adeguarsi alle nuove norme emanate dalla Regione e hanno chiuso. Peccato, dico io, sapevano amare.

Noi ci siamo adeguati e abbiamo stipulato un accordo con il Comune. Ma allora si è cominciato a parlare di soldi, di assumere personale qualificato, di fare progetti e… si sono moltiplicati i pensieri.

Siamo ancora qui, malgrado le difficoltà da superare quotidianamente, per portare avanti l'impegno assunto, tenendo a mente le parole di don Gino
(4)
Don Gino Piccio, sacerdote del gruppo di missionari di monsignor Moietta.
: "Non dimenticare le tue radici"".
Note
| (1) | Monsignor Carlo Chiavazza, fondatore del settimanale Il nostro tempo, rappresentava in quella circostanza la Chiesa torinese. |
| (2) | Monsignor Vittorio Moietta, futuro vescovo di Nicastro, era direttore spirituale del Seminario di Casale e di Villa Serena. |
| (3) | Don Giuseppe Viotti, fondatore del Santuario Nostra Signora di Lourdes a Giaveno, aveva precorso i tempi dando vita a comunità con pochi bambini ospiti, il modello adottato dopo la chiusura degli istituti. |
| (4) | Don Gino Piccio, sacerdote del gruppo di missionari di monsignor Moietta. |